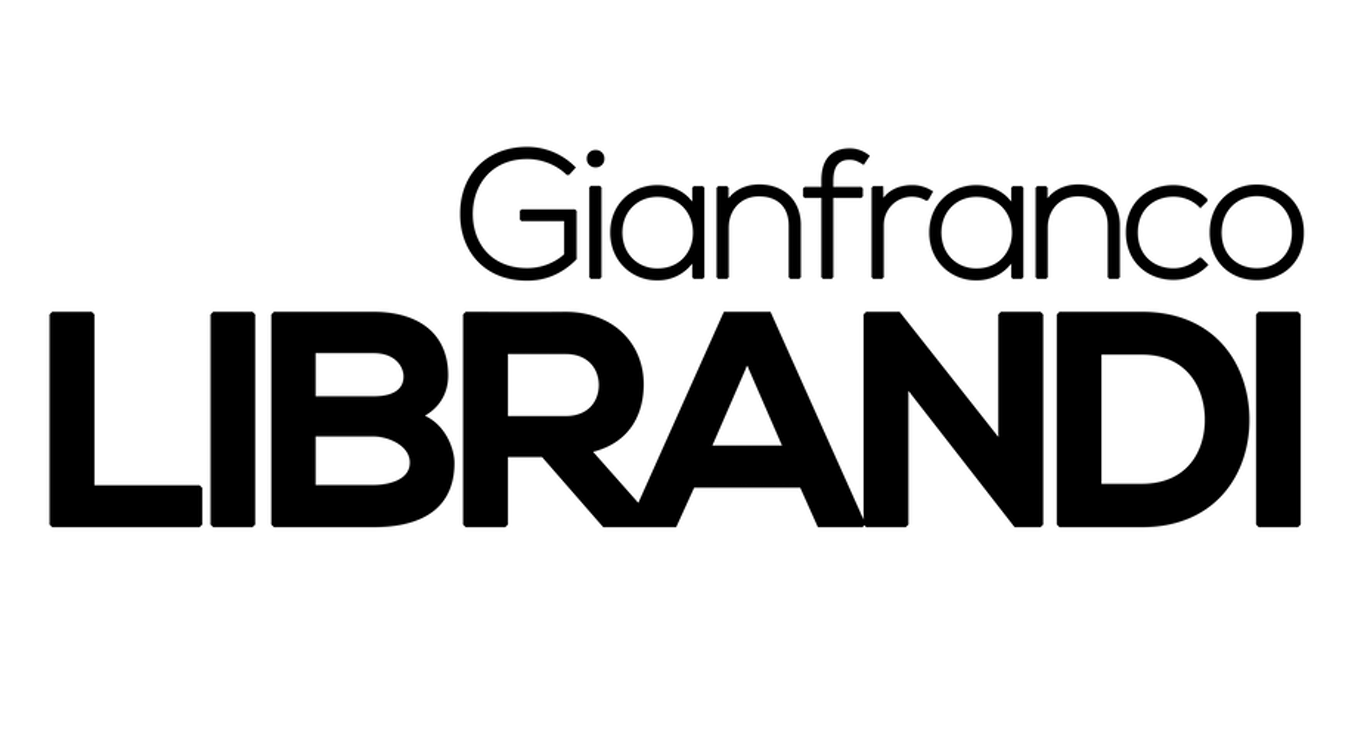Ecco a voi il mio editoriale di oggi su Stradeonline.it:
Ecco a voi il mio editoriale di oggi su Stradeonline.it:
di Gianfranco Librandi.
C’è un equivoco di fondo nel dibattito politico italiano: che esista una contrapposizione tra rigore e crescita, come se il primo inibisse la seconda o come se la crescita avesse bisogno di finanze pubbliche allegre o comunque in deficit per realizzarsi. Tale contrapposizione non esiste, così come non esiste alcuna correlazione tra l’euro e la crisi economica italiana. C’è chi vuol trascinare il confronto politico-elettorale dei prossimi due mesi sul campo della demagogia, in uno sterile dibattito “3% sì, 3% no” o “euro sì, euro no”.
Noi “rigoristi” non consideriamo la soglia del 3% per il rapporto deficit/Pil come un feticcio ideologico. Ha ragione chi dice, citando anche autorevoli studi economici, che non c’è alcuna evidenza empirica che assegni a quel “numero” – il 3% – un significato assoluto. D’altronde, nemmeno il 4, il 6 o l’8% avrebbero un significato cogente. Più che il numero, vale il principio della credibilità di un governo: chi investe nel debito pubblico italiano, confida sul rispetto degli impegni assunti da parte dello Stato italiano. Il 3% è un impegno, come è un impegno ripagare il debito: se solo si incrinasse la fiducia dei creditori, i tassi d’interesse salirebbero vertiginosamente e l’Italia non sarebbe in grado di onorare un debito pubblico superiore al 130% del Pil. Le parole credito e credibilità hanno la stessa radice etimologica. Un paese altamente indebitato, che ogni settimana emette titoli per molti miliardi, non può permettersi il ritorno di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europa. Lo sforamento del 3% potrebbe essere l’effetto di politiche di riforma altamente credibili ed efficaci per una crescita della produttività, non un obiettivo in sè.
C’è da essere onesti intellettualmente quando si muovono critiche alla “austerità”: o pensiamo che la parità tra entrate e uscite sia un valore prezioso per uno Stato sano o crediamo che lo Stato italiano possa permettersi ancora di spendere più di quanto incassa. Inutile girarci intorno. La seconda opzione, che nei decenni passati è stata ampiamente utilizzata, oggi è impossibile, se l’Italia vuol restare solvibile. In un contesto di pareggio di bilancio obbligato oltre che moralmente doveroso, il tema diventa allora quello della qualità della spesa, anche a parità di importo complessivo. Vi sono ampissimi margini di trasformazione di spese improduttive in spese più efficaci. La spesa sociale, ad esempio, merita ancora un riequilibrio tra previdenza e spesa per ammortizzatori sociali: troppo alta la prima e troppo bassa la seconda. Nell’ambito dell’istruzione, paghiamo pochi gli insegnanti e sprechiamo molte risorse nella macchina amministrativa. C’è da disboscare il campo dei sussidi alle imprese, in cambio di detassazioni e investimenti in innovazione, tecnologia, ambiente.
Dopo la buona notizia del via libera della Corte tedesca al Fondo Salva Stati, dobbiamo sederci intorno ad un tavolo con i partner europei e dire loro: riformiamo la governance europea, facciamo un passo in avanti verso un’unione fiscale. Non è giusto che l’Europa intera resti sospesa alla decisione di un giudice a Karlsruhe, occorre maggiore democrazia europea. Ma l’Italia deve ritrovare il gusto e il coraggio di giocare, non in difesa! Dobbiamo essere chiari con i cittadini: vogliamo che l’Italia torni il paese della lira debole, esposta alla speculazione e all’inflazione? Vogliamo il deprezzamento delle nostre case e dei nostri patrimoni? Da imprenditore che esporta nel mondo, vi dico che il vantaggio di una svalutazione competitiva svanisce in pochi mesi, mentre una moneta solida e affermata nel mondo è un vantaggio enorme per chi produce e investe. L’economia mondiale parla in euro, dollaro, yen e yuan, non serve un nuovo marengo padano.